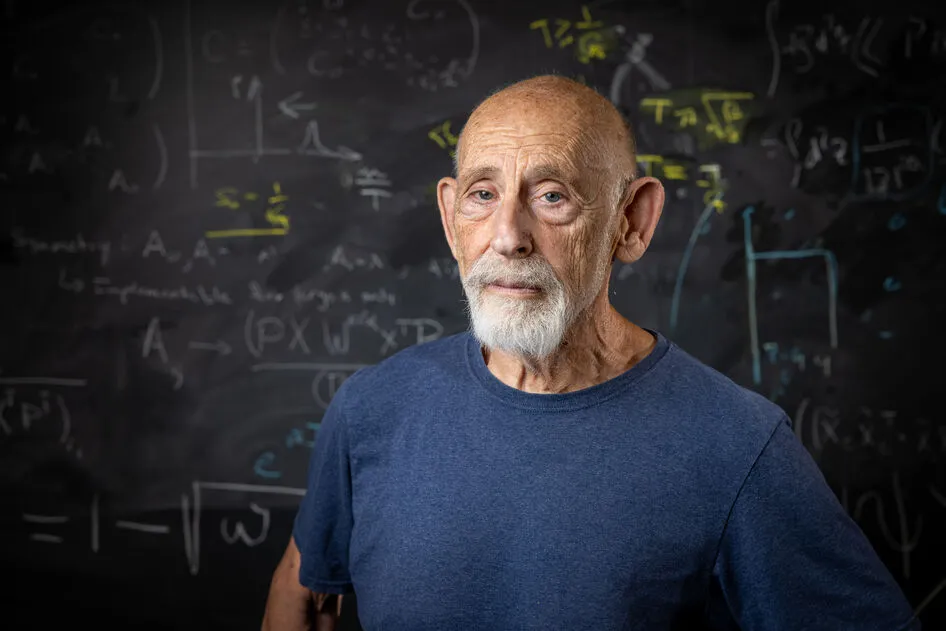Intervista a Ilaria Marcolini, responsabile delle attività di marketing, comunicazione e pubbliche relazioni di Fraunhofer Italia
Che cos’è Fraunhofer Italia?
Fraunhofer Italia è la prima e al momento unica sede italiana della più ampia società Fraunhofer-Gesellschaft, una delle organizzazioni leader a livello mondiale nel campo della ricerca applicata. Siamo nati alla fine del 2009 a Bolzano, grazie alla volontà e visione di Assoimprenditori Alto Adige, che ha avvertito chiaramente la necessità di un ente di ricerca applicata a supporto delle aziende del territorio. Non soltanto, infatti, siamo parte del network della Fraunhofer-Gesellschaft, con cui intratteniamo scambi continui, ma anche del NOI Techpark, il parco tecnologico di Bolzano, un vero e proprio hub dell’innovazione. Ci siamo trasferiti all’interno del NOI nel 2017, affiancando l’Università di Bolzano, altri due centri di ricerca e numerosissime startup e aziende altoatesine, e contribuendo a un ecosistema in forte crescita che sta ridefinendo il profilo industriale del territorio rendendolo un distretto moderno e sostenibile. In questo contesto, ARENA, il nostro centro applicativo, è lo spazio in cui lavoriamo, testiamo e validiamo soluzioni inedite, con l’obiettivo di trasformare la ricerca in applicazioni reali per l’industria.
Come riuscite in questa impresa?
Rispetto alla ben più ampia Fraunhofer-Gesellschaft, con oltre 30.000 collaboratori e circa 70 istituti in Germania, il nostro centro – con un team di circa 40 persone – si distingue per le dimensioni contenute, che ci consentono grande flessibilità, rapidità decisionale e un rapporto diretto con il tessuto industriale. Manteniamo però l’approccio tedesco, anche in termini di finanziamenti: un terzo proviene dalla Provincia Autonoma di Bolzano, un terzo dai progetti europei, un terzo dall’industria. Supportiamo principalmente aziende di piccole o medie dimensioni, che presentano un problema e mancano degli strumenti o delle competenze per risolverlo. Le nostre soluzioni spaziano dalla robotica avanzata all’automazione, alla digitalizzazione dei processi di costruzione; e abbiamo un team trasversale dedicato alla bioeconomia e alla sostenibilità. Operiamo quindi con le aziende una doppia trasformazione: digitale e sostenibile.
Quale percorso affrontate insieme alle aziende?
Quando le aziende si rivolgono a noi è perché vogliono vagliare in un “ambiente protetto” (un ambiente in cui sperimentare in sicurezza) diversi approcci ai loro problemi, prima di decidere di investire somme ingenti nella loro soluzione. Perciò procediamo per gradi, il primo dei quali è l’indagine preliminare. In questa fase conoscitiva, mappiamo il problema: studiamo il contesto, raccogliamo informazioni, analizziamo i dati e stimiamo i rischi. Si tratta di un passaggio cruciale per ridurre l’incertezza e aumentare le probabilità di successo. Se poi queste probabilità di successo sono buone, ci dedichiamo subito alla stesura del progetto completo, ma se il rischio di non raggiungere il risultato prefissato è abbastanza elevato e si rendono necessarie ulteriori verifiche, passiamo allo studio di fattibilità: un’indagine più approfondita, in cui vengono esaminati in dettaglio tutti gli aspetti tecnici, operativi, economici. Questa fase è contrattualizzata e può durare dai 3 a 6 mesi, e mira proprio a verificare la solidità del progetto e a fare una stima del valore che potrebbe generare. Volendo fare un esempio pratico, potremmo avere un cliente interessato ad automatizzare o snellire un processo svolto manualmente. Dall’indagine preliminare emergono risultati incerti e quindi ci si accorda su uno studio di fattibilità di sei mesi durante il quale riproduciamo in ARENA, il nostro laboratorio, un passaggio o un blocco produttivo del cliente in questione. In questo modo siamo in grado di seguire da vicino tutti i passaggi del processo produttivo, replicandone tempistiche e problematiche, e possiamo testare in maniera immediata le soluzioni. Lo scopo è proprio quello di definire con chiarezza la fattibilità tecnica e il potenziale ritorno dell’automazione, riducendo al minimo i rischi di investimento del cliente.
Che cosa succede se dopo l’esito positivo dello studio di fattibilità, e dunque l’effettiva implementazione della soluzione presso l’azienda richiedente, emergono dei problemi?
Dipende. Noi lavoriamo sullo sviluppo di software, sugli algoritmi, mentre la struttura hardware è sempre affidata a terzi. E il “pacchetto completo” che riceve l’azienda cliente richiede l’intervento di un attore ulteriore: l’integratore di sistema, un’azienda specializzata proprio nell’integrazione di hardware e software. Perciò un eventuale guasto a seguito dell’implementazione viene gestito da noi soltanto se interessa l’algoritmo. Capita poi che l’azienda cliente disponga già, per esempio, di un braccio robotico e che voglia riconfigurarlo per lo svolgimento di nuove attività o ottimizzarne le prestazioni. A quel punto, il processo è gestito direttamente da noi in ARENA. Gli attori coinvolti e le modalità di coinvolgimento non sono mai gli stessi: a volte siamo noi a fare da tramite con fornitori e integratori di sistema, a volte sono loro a invitarci, e a volte, come dicevamo, è la stessa azienda cliente a fare da raccordo.
Parlando di robotica, di che tipo di progetti vi occupate?
Un macro-concetto su cui ci stiamo concentrando al momento è il grasping, la tecnica di presa dei robot. Questa entra in gioco, per esempio, nel bin picking (presa alla rinfusa): siamo in un grande magazzino, popolato da oggetti diversi, con configurazioni geometriche e dimensioni molto differenti tra loro, e il braccio robotico deve riconoscere e prelevare oggetti specifici. Attraverso i digital twin (gemelli digitali), simuliamo le varie configurazioni di presa del robot in maniera il più possibile aderente alla realtà, e definiamo e scriviamo algoritmi adatti non solo a riconoscere l’oggetto, ma anche a individuare il tipo di pinza con cui prelevarlo – pinze a due dita, a ventosa, magnetiche – e il movimento da compiere. In questo caso andiamo ad automatizzare un processo, ma ci dedichiamo anche a progetti di robotica cosiddetta collaborativa, cioè basata sull’interazione uomo-macchina.
Ci può fare qualche esempio?
Certo, partiamo da un progetto concluso, CONCERT, sviluppato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia, la Technical University di Monaco e diverse aziende, tra cui un’impresa edile polacca che ha fatto anche da utente finale. CONCERT è stato un progetto di robotica avanzata applicata all’edilizia, con l’obiettivo di introdurre nei cantieri una piattaforma robotica riconfigurabile a supporto degli operatori. Il sistema, basato su un braccio robotico modulare, poteva essere adattato a diverse attività – dalla pittura al trasporto collaborativo, dalla foratura delle pareti alla raccolta di dati tramite fotografie. Il concetto di riconfigurabilità, inteso come estensione della flessibilità, si concretizzava nella possibilità di assemblare i moduli del braccio per ottenere la configurazione più idonea e coerente con la specifica applicazione. La struttura modulare garantiva inoltre un’interazione semplice e intuitiva, che consentiva anche a utenti non esperti di modificare la configurazione senza necessità di formazione specialistica. Tra i principali obiettivi di CONCERT vi era proprio quello di rendere l’utilizzo dei robot accessibile e immediato, ampliandone le potenzialità applicative in contesto edilizio. Il progetto, recentemente concluso, rientra nel programma europeo Horizon. Inclusione e robotica collaborativa entrano poi anche nel progetto Inclu5ion, ancora in corso, e pensato per aiutare le persone con disabilità, consentendo loro di adattare la propria postazione – e dunque la propria modalità di lavoro – alle esigenze individuali. In questo caso, stiamo lavorando su un’interfaccia uomo-macchina in grado di analizzare il comportamento degli operatori per adattare il livello di assistenza fornita. Uno dei parametri è, per esempio, quello dell’eye-contact (contatto visivo): si monitora il numero di volte in cui l’operatore sbatte le palpebre e – sempre grazie alla scrittura di algoritmi coerenti – il robot adatta il proprio intervento a seconda del livello di stanchezza rilevata.
Che cosa frena oggi le aziende dall’investire in queste soluzioni?
Sicuramente c’è il tema economico, su cui impattano la disponibilità di fondi regionali per la ricerca e l’innovazione, la dimensione e le modalità di gestione dell’azienda, e anche la capacità di visione di chi la guida. È chiaro che in alcuni contesti, come le aziende padronali, riuscire a vedere i benefici che potrebbe portare l’innovazione non è sempre immediato. E in questi casi lo studio fattibilità rappresenta proprio una leva, l’inizio di un processo di apertura. Ma entrano in gioco anche altri fattori, come la disponibilità di tempo e di risorse umane. Quando avviamo un progetto di ricerca applicata con un’azienda, abbiamo bisogno di una collaborazione strettissima, e questo richiede una forte motivazione. In più, nel caso della robotica, sorgono spesso grandi perplessità rispetto all’inserimento dei robot nel contesto lavorativo, perché si teme sostituiscano le persone che svolgono correntemente la stessa mansione. Per noi la robotica solleva e non sostituisce, libera l’operatore da incarichi gravosi, ne minimizza i rischi, e gli concede il ruolo di supervisore e gestore. È però un tema molto delicato, ci sono punti di vista molto differenti, ed è fondamentale discuterne insieme. ARENA in questo senso non è soltanto il nostro laboratorio, è anche lo spazio in cui favoriamo l’incontro tra industria e ricerca, dialoghiamo con le aziende, traduciamo le nostre idee in applicazioni industriali.
In quali settori vede le maggiori opportunità per Fraunhofer Italia nei prossimi anni?
Ci piacerebbe molto riuscire a traslare le forti competenze acquisite in ambito manifatturiero al settore della sanità e dell’assistenza. Faccio riferimento, per esempio, alla robotica. Se oggi concentriamo le nostre competenze nello sviluppo di robot per l’edilizia e il manifatturiero – capaci di muoversi in autonomia, evitare ostacoli e collaborare con l’utente – domani vorremmo applicare queste stesse conoscenze al settore sanitario e dell’assistenza, per creare robot e bracci robotici in grado di supportare il personale medico e facilitare i percorsi di riabilitazione dei pazienti. Ci sono poi tre ambiti – produzione e logistica, costruzione, spazio – su cui la robotica collaborativa può avere un grande impatto: dalla produzione flessibile alla smart automation nel settore produttivo e logistico, all’impiego di droni per l’ispezione o alla collaborazione tra droni e robot nell’ambito delle costruzioni. E sebbene non abbiamo ancora alcuna esperienza diretta del settore spaziale, possiamo facilmente immaginare l’impiego di robot autonomi e riconfigurabili per le attività di esplorazione spaziale o per la manutenzione di strutture in orbita. Al momento siamo ancora orientati sul manifatturiero e l’industriale, ma ci sono sicuramente altre vie interessanti.
BIO
Ilaria Marcolini coordina le attività di marketing, comunicazione e PR per Fraunhofer Italia, contribuendo alla valorizzazione della ricerca applicata attraverso iniziative pubbliche, collaborazioni strategiche e progetti di divulgazione.